Ai ragazzi del Circolo Culturale il Leonardo
Napoli 1962
“Che giornata! L’odore della bella giornata, proprio l’odore.”
A Napoli si sente quando sta arrivando.
Non c’è nulla come quei refoli di aria che portano con sé antichi suoni, piccoli venti giunti da lontano, pieni di profumi accumulati nel viaggio, petali di fiori.
Non c’è nulla “comme nà bella iurnata ‘e sole”.
Non quel caldo che afferra la testa irritandoti, ventaglio e bottiglia d’acqua in borsa.
Non quello sciapo tepore un po’ velato che non serve a nulla, ma quel cielo azzurro azzurro, quell’aria frizzantina, quel calore odoroso di glicini, di gelsomini e di basilico.
Piante ai davanzali, braccia di donne appena scoperte, ancora col chiarore della pelle, ma ambiziose e vogliose del colore bronzeo dei raggi di sole.
E la bella giornata è anche una lontana speranza, un desiderio: vedere di nuovo le rondini, appropriarsi di una città che si sta svegliando, unica, indefinita, complessa città di amori e di odii. Napoli non è una visione astrale, una città da raggiungere un giorno: Venezia, Mosca, New York.
Napoli è una città da scoprire giorno per giorno, luogo invisibile, mancanza d’uomo, annotazione di tutto il bello che emoziona e commuove.
Proprio come accade quando apri la finestra su di una bella giornata e prendi fiato per la meraviglia.
Eppure Napoli è sempre stata descritta con pennellate scure, disegnata a tratti forti, come se ciascuno, scrittore autore regista, avesse sulla tavolozza solo il profondo e cupo nero.
Sempre vicoli bui, piccole vite, donne e uomini disperati: povertà. “Ricchiuni e zoccole”
Una città di mare senza mare, un vulcano incombente mai spento e mai amico, un popolo di lamentosi desideri inesauditi.
Il napoletano è una figura ambigua, senza altro sentimento che il desiderio del godimento di sé.
La sua priorità è quella di rappresentare perennemente la “notoria” simpatia, la falsa empatia, la immaginaria generosità.
Ho scritto di questa città e delle sue piccole bellezze. E quando andavo per strade e vicoli, “scoprendo” monumenti e rari alberi; piazze senza fontane e fontane senza acque; funicolari in salita e vele bianche; fortezze e maschi angioini, mi innamorai perdutamente delle mura delle chiese chiuse, dei balconi e delle araucarie. Era tutto alla mia portata e ogni cosa aveva storie da raccontare.
Amare la mia città fu facile, guardarla con occhi devoti, ringraziarla per la bellezza seppur difficile da scoprire, nascosta ad occhi non vedenti, aperta a chi volesse vedere.
Meravigliosamente questa è la città che ho ritrovato leggendo tardi, veramente molto tardi, “Ferito a morte”.
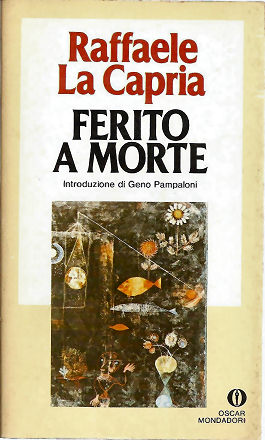
Per rappresentare la dispersione del futuro, lo spreco di anime, le scelte politiche nefaste, il vivere irrisolto e insensato, la povertà di mente e di cuore non è necessario intingere il pennello nel nero assoluto.
I grandi artisti hanno raccontato l’orrore usando parole dolci, immagini solari, sinfonie bellissime.
La voce di Billy Holliday che canta Strange fruit, il campo di girasoli di Van Gog con gli uccelli neri che volano via, Manhattan di Woody Allen, la Messa di Requiem di Mozart.
La Napoli di La Capria si apre come una porta finestra che guarda il mondo, con i suoi soli, i suoi mari azzurri turchesi e blu, le terrazze di rosso cotto, di vasi di basilico e maggiorana, di salvia fiorita e di menta profumata di zucchine fritte alla scapece.
Napoli che ferisce a morte è la protagonista del libro che mi è entrato nel cuore.
La Napoli di Grotta Romana, del mare che ondeggia sotto i palazzi di Posillipo, di giardini che si tuffano in acqua, Napoli assolata, calda, madre e amante, la Napoli stregata da Munacielli e Belle Imbriane, dei silenzi e dei boati.
Io amo napoli dei giardini segreti, napoli di strade di campagna strette nel cuore della città, napoli di belle metropolitane e di anime perse, napoli di mille chiese e di musei chiusi, napoli delle parole scritte, dei profumi improvvisi, dei venticelli che sanno di Mediterraneo, napoli di funicolari capresi, di cascate di glicini in fiore giù da terrazze e balconi, napoli di giardini pensili, di giardini come foreste, napoli di grida notturne che avvertono ladri e trafficanti dell’arrivo della polizia, napoli di casalinghe affette da ludomania che si giocano pensioni e assegni d’invalidità, napoli di uomini che per disperazioni si buttano giù da balconi al quinto piano, napoli di persone che trovano divertente che qualcuno si tolga la vita gettandosi dal quinto piano.
Ferito a morte parla anche di questo, e di come il volto della città sia stato stravolto, violato, stuprato dal desiderio di dominio di una classe politica ancora legata al vecchio regime, in coma ma non deceduto, che aveva il suo massimo esponente in un uomo ambizioso, cinico, ingombrante e profondamente antidemocratico: il Comandante Achille Lauro, ricco armatore, tardo monarchico, sincero conservatore, convinto capitalista.
Simbolo di un mondo di Potenti e di servi, in cui si compra un voto con un pacco di pasta, con una scarpa spaiata, con la metà di una banconota: metodi mafiosi, sempre utili per i propri interessi.
E gli interessi di Lauro erano concentrati in un unica cosa: la speculazione edilizia.
Complici i politici, gli appaltatori, i costruttori “amici”.
Un nome su tutti Mario Ottieri: imprenditore edile. Uomo per tutte le stagioni.
Nel film “Le mani sulla città” di Francesco Rosi del 1963 Ottieri si chiama Nottola, un nome simbolico, che ricorda un animale notturno, un pipistrello, uno dei più grandi della specie: colore bruno rossiccio, orecchie e ali nerastre che vive prevalentemente nei boschi, si nutre di insetti al crepuscolo e di notte, di giorno si rifugia in cavità naturali e artificiali, il suo nome comune è “succiacapre”, il suo nome nella leggenda è “ vampiro”.
Questo film si può considerare l’ultimo capitolo di Ferito a morte.
La Capria ne è uno degli sceneggiatori, dopo due anni dall’uscita del suo libro, dopo anni di “fuga“ dalla città insieme a tanti altri che la lasciarono per poter meglio respirare.
Ed è anche il tema del libro: il senso di colpa per non essere rimasto.
Negli anni 60 i giovani intellettuali discussero a lungo sulla necessità di restare, di non lasciare Napoli per combattere faccia a faccia contro quel Potere dalle aspirazioni camorristiche e dall’indole spregiudicata, pronta a tutto.
Il film inizia con una carrellata su di una zona desolata in collina, oggi Vomero alto con Via San Domenico: è là che dovrà nascere un agglomerato di case di lusso, aggrovigliate e affastellate lungo un viottolo di campagna, stretto in salita, circondato e “abbellito “ dalla tangenziale.
Il progetto è aggiungere al panorama di palazzi e case altro cemento di case e palazzi.
Soccavo, Fuorigrotta, Rione Traiano …fino ad abbattere case nel centro storico e ricostruire. Cementificare il mondo.
Un incubo incontenibile e incontrastato.
Il film, di un’attualità inquietante, è una seduta della giunta, una lunga, ripetuta riunione di consiglieri, assessori a Palazzo San Giacomo.

Il piglio documentaristico, il crudo bianco e nero senza abbandoni, l’interpretazione magistrale di Rod Staiger e Salvo Randone, la naturale veemenza politica di Carlo Fermariello, che interpreta se stesso, fanno di questo film un piccolo gioiello.
Che racconta, come accade oggi nei confronti della delinquenza organizzata, che tutti i partiti hanno usufruito dei servizi di imprenditori disonesti, in termini di denaro profuso, di raggiungimento del potere, di accumulo di privilegi.
E la figura un po’ ridondante di Carlo Fermariello, dirigente del PCI di quegli anni, che contrasta fortemente con gli altri personaggi più rarefatti, è il simbolo della rivolta, della opposizione ad un regime che si è sempre nutrito di se stesso, rinnovandosi e risorgendo mille e mille volte.
E’ anche il simbolo della disfatta, dell’occasione perduta, della impossibilità di trasformare il mondo.
“La spigola, quell’ombra grigia, profilata nell’azzurro, avanza verso di lui e pare immobile, sospesa, come una fortezza volante quando la vedevi arrivare ancora silenziosa nel cerchio tranquillo del mattino. L’occhio fisso, di celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata di una maschera cinese- è vicina, vicinissima, a tiro. La Grande Occasione. L’aletta dell’arpione fa da mirino sulla lingua smagliante del fucile, lo sguardo segue un punto tra le branchie e le pinne dorsali. Sta per tirare- sarà più di dieci chili, attento, non si può sbagliare!- e la Cosa Tremula si ripete: una pigrizia maledetta che costringe il corpo a disobbedire, la vita che nel momento decisivo ti abbandona. Luccica lì, sul fondo di sabbia, la freccia inutile.”
Così La Capria inizia “Ferito a Morte”, con la metafora di una sconfitta.




